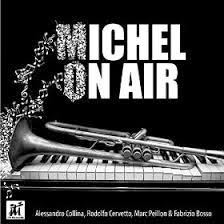VAN MORRISON
DUETS: RE-WORKING THE CATALOGUE
 Sedici canzoni dal
repertorio di Van The Man, scelte evitando volutamente quelle più famose,
ricreate ognuna con un diverso e stimato collega per altrettanti imperdibili
duetti. Questo il riassunto di un ipotetico comunicato ufficiale. La realtà è
che dischi così arrivano a fine carriera e hanno il pregio di impegnare
relativamente l’artista: dal punto di vista creativo (si usano brani già
editi); da quello produttivo (non penserete che i duetti vengano registrati de
visu? Ognuno sta a casa, incide con i suoi tempi e i suoi modi, poi si sistema
tutto); da quello fisico (la voce comincia a calare e l’aiuto rispettoso è ben
accetto). E finiscono per assomigliare all’orologio d’oro regalato al
pensionando con encomio solenne; o a una pietra tombale. Anche questo del
burbero artista di Belfast non sfugge alla regola: si convoca un po’ di nomi
altisonanti - giovani, anziani, donne, uomini, figli, vivi, morti (il bacino
dev’essere il più ampio possibile) e il gioco è fatto: come ci ha detto nel suo
ultimo disco, Morrison non ha un piano B, sa solo cantare e probabilmente
continuerà a farlo fino a che avrà voce e ispirazione. E magari anche dopo.
Sedici canzoni dal
repertorio di Van The Man, scelte evitando volutamente quelle più famose,
ricreate ognuna con un diverso e stimato collega per altrettanti imperdibili
duetti. Questo il riassunto di un ipotetico comunicato ufficiale. La realtà è
che dischi così arrivano a fine carriera e hanno il pregio di impegnare
relativamente l’artista: dal punto di vista creativo (si usano brani già
editi); da quello produttivo (non penserete che i duetti vengano registrati de
visu? Ognuno sta a casa, incide con i suoi tempi e i suoi modi, poi si sistema
tutto); da quello fisico (la voce comincia a calare e l’aiuto rispettoso è ben
accetto). E finiscono per assomigliare all’orologio d’oro regalato al
pensionando con encomio solenne; o a una pietra tombale. Anche questo del
burbero artista di Belfast non sfugge alla regola: si convoca un po’ di nomi
altisonanti - giovani, anziani, donne, uomini, figli, vivi, morti (il bacino
dev’essere il più ampio possibile) e il gioco è fatto: come ci ha detto nel suo
ultimo disco, Morrison non ha un piano B, sa solo cantare e probabilmente
continuerà a farlo fino a che avrà voce e ispirazione. E magari anche dopo.
recensione scritta il 28 febbraio – disco in uscita il 24 marzo
“Some Peace of
Mind” con Bobby Womack (da Hymns
to the Silence, 1991)
“Lord, If I Ever
Needed Someone” con Mavis
Staples (da His Band and the Street Choir, 1970)
“Higher Than The
World” con George Benson (da Inarticulate Speech of the Heart, 1983)
“Wild Honey” con
Joss Stone (da Common One, 1980)
“Whatever
Happened to P.J. Proby” con
P.J. Proby (da Down the Road, 2002)
“Carrying a
Torch” con Clare Teal (da Hymns
to the Silence, 1991)
“The Eternal
Kansas City” con Gregory
Porter (da A Period of Transition, 1977)
“Streets Of
Arklow” con Mick Hucknall (da Veedon
Fleece, 1974)
“These Are The
Days” con Natalie Cole (da Avalon
Sunset, 1989)
“Get On With The
Show” con Georgie Fame (da What’s
Wrong with This Picture, 2003)
“Rough God Goes
Riding” con Shana Morrison (da
The Healing Game, 1997)
“Fire in the
Belly” con Steve Winwood (da The
Healing Game, 1997)
“Born To Sing” con Chris Farlowe (da No Plan B, 2012)
“Irish Heartbeat”
con Mark Knopfler (da Irish Heartbeat, 1988)
“Real Real Gone” con Michael Bublé (da Enlightenment, 1990)
“How Can A Poor
Boy” con Taj Mahal (da Keep
It Simple, 2008)